Una delle battute più ricorrenti che i luterani rivolgevano ai cattolici era quella di avere una tale premura nei confronti della Sacra Scrittura da lasciarla devotamente intonsa sulle mensole delle proprie librerie di casa. Questo rapporto, fortunatamente, dopo il Concilio Vaticano II è cambiato e anche i cattolici sono invitati a recuperarne familiarità non soltanto nella contesto della celebrazione liturgica ma anche nei pii esercizi e nella pratica quotidiana. È proprio di queste settimane il successo dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo Il Dio dei nostri padri. Il romanzo della Bibbia. Il suo è un romanzo, appunto, interessante, certo. Ma né più né meno di una lettura personale di un testo che ci interroga di pagina in pagina, di storia in storia, di racconto in racconto. Sono tante invece le edizioni commentate, dalla Bibbia di Gerusalemme, alle edizioni CEI, alla recente Bibbia essenziale del Pellegrino, quest’ultima come una sintesi (forse inclemente) di passi scelti.
In fondo la Bibbia non è un libro, ma una raccolta di libri. Una “biblioteca” che racconta, con stili e generi letterari diversi, il problematico rapporto intessuto tra l’uomo e Dio. Di certo la parte a noi più familiare è quella del nuovo Testamento, su tutti i quattro Vangeli che raccontano l’esperienza di Gesù e che il Papa ci ha invitato a portare sempre in tasca e consultare con frequenza durante la giornata.
Ma perché recuperare questa familiarità è così importante? E perché è bene che il testo si “maneggi con cura”, con la cura dovuta a qualcosa di prezioso e senza fermarsi a letture decontestualizzate e astoricamente letterali?
Proprio il Concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica Dei Verbum chiarisce che «poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l’interprete della Sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole» (DV12). Di qui l’importanza di educarsi alla lettura contestuale della Bibbia, tenendo conto dei generi letterari e delle circostanze in cui i testi sono stati scritti. Ecco allora perché la Chiesa si premura di accompagnare sempre più i fedeli a una comprensione del testo sacro auspicando «che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura» (DV 22). È in questa prospettiva che Papa Francesco ha voluto indire ogni terza domenica del tempo ordinario (la terza domenica dopo il tempo di Natale) la Domenica della Parola di Dio. Non è casuale che siamo nella Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, e a ridosso della Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei. Come evidenzia Papa Francesco, infatti, «celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida».
Una giornata dedicata a creare una crescente familiarità con le Sacre Scritture nella convinzione più volte espressa dal Papa che «per il credente, la Parola di Dio non è semplicemente un testo da leggere, la Parola di Dio è una presenza viva, è un’opera dello Spirito Santo che conforta, istruisce, dà luce, forza, ristoro e gusto di vivere».
San Girolamo, il traduttore ufficiale della versione in latino, sottolineava che «non possiamo mai da soli leggere la Scrittura. Troviamo troppe porte chiuse e scivoliamo facilmente nell’errore». Oggi la Chiesa ci invita a farlo, ma ci sollecita anche a farlo con la dovuta preparazione o con il dovuto accompagnamento pastorale. Come ci mostrano tanti fondamentalismi, infatti, i rischi di travisamento, distorsioni e strumentalizzazioni sono sempre dietro l’angolo.
La Bibbia è un dialogo continuo tra l’uomo e Dio, ancora oggi. Non soltanto come “romanzo” o resoconto storico ma come esperienza di una relazione che è stata raccontata nei secoli, sia prima (Antico Testamento) che dopo (Nuovo Testamento) l’avvento di Gesù Cristo. Ciascuno è invitato a riconoscere che siamo parte di una storia umana, che siamo chiamati quotidianamente a fare un’esperienza, noi oggi, come tanti altri. nei tempi antichi. La Parola di Dio ci parla di un desiderio di Dio di dialogare con ciascuno di noi.
Questa Domenica vuole essere un semplice, discreto, puntuale POST-IT…
(c) Vito Rizzo 2025
[Articolo pubblicato sul quotidiano Le Cronache di Salerno del 26 gennaio 2025]
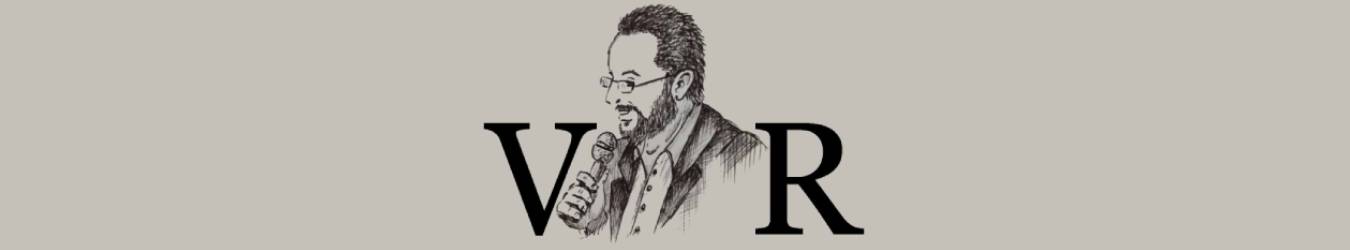
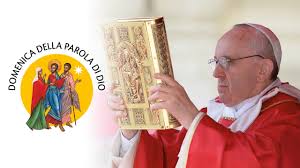
Leave a Reply